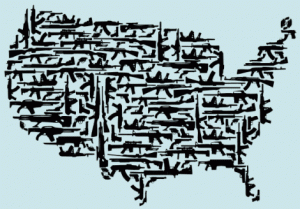 Circa due mesi fa gli Usa hanno conosciuto l’ennesimo “massacro” stile campus universitari, questa volta “mini” per fortuna, che tanto lasciano sgomento il mondo e, almeno in parte, gli Usa stessi. Sto parlando dell’uccisione in diretta di due reporter in Virginia. L’assassino ha poi “postato” (un termine moderno che mi fa orrore quasi quanto il massacro) il video dell’assassinio sul web.
Circa due mesi fa gli Usa hanno conosciuto l’ennesimo “massacro” stile campus universitari, questa volta “mini” per fortuna, che tanto lasciano sgomento il mondo e, almeno in parte, gli Usa stessi. Sto parlando dell’uccisione in diretta di due reporter in Virginia. L’assassino ha poi “postato” (un termine moderno che mi fa orrore quasi quanto il massacro) il video dell’assassinio sul web.
Sono stato negli Stati Uniti per la prima volta nel 1995 perché avevo trovato moglie americana. Ci ho vissuto per due anni e poi ci sono tornato almeno una volta all’anno. Nel corso di questi venti anni ho girato il Paese in lungo e in largo, soprattutto con gli autobus Greyhound che sono quelli dei poveracci che non sono riusciti (alcuni non hanno voluto semplicemente perché non ci hanno mai creduto) a raggiungere l’american dream. Sono i reietti della società americana. Sono, in altre parole, la vera America che non è, come tanti ingenuamente credono, quella luccicante delle “Grandi Mele”, delle freeways della libertà e dei film di Hollywood.
Viaggiando così ho imparato molto naturalmente, quando mi trovo negli Usa, ad avere paura. Del resto chiunque abbia un minimo di sensibilità (intesa nella sua accezione di capacità di “sentire”) è in grado di avvertire la violenza ed aggressività di cui questa società è intimamente intrisa. E’ una paura di pelle e di pancia che va ben oltre la ragione; si tratta di una paura che potrei definire “empatica”. C’è poco da spiegare. La si avverte e basta. E’ così.
Quando me ne andavo a zonzo per una qualunque città, rimanevo sempre sgomento nel vedere i negozi di armi (che soprattutto nel sud del Paese sono una normalità assoluta) che si trovano semplicemente ovunque: nei centri commerciali come di fianco a una gelateria o ad una lavanderia a gettone. Più di una volta sono entrato e ho chiesto di vedere pistole e fucili. Me le hanno mostrate e me le avrebbero vendute senza batter becco (del resto altrimenti che stanno lì a fare?), senza chiedere nulla, nemmeno un documento, esattamente come si vende un cono gelato.
Per l’americano medio tutto ciò è normale. La cosa è peraltro logicamente spiegabilissima se pensiamo che questo Paese è stato letteralmente costruito su uno spaventoso genocidio, quello dei Nativi, e da quel genocidio sono arrivati ad essere, con pieno orgoglio, l’impero più potente nel corso della storia. Il fanatismo patriottico violento degli statunitensi si spiega anche così. Del resto “right or wrong, my country”.
A luglio di quest’anno mi trovavo ad Ithaca (che per inciso è una cittadina del nord-est, alternativa e progressista, lontana anni luce da quelle fanatico-razziste del sud del Paese) e camminavo sotto un acquazzone torrenziale quando mi sono fermato sotto la pensilina di uno studio dentistico che dava sulla strada. Era una domenica mattina ed era tutto chiuso ed io, del tutto sovra pensiero (e sbagliando, è ovvio), ho infilato nella cassetta della posta (quelle tipiche americane, grandi e lunghe) un bicchiere di carta del caffè che tenevo in mano da mezz’ora. E’ uscito un tipo dallo studio dentistico che, pistola alla mano e con una violenza ed aggressività verbale semplicemente allucinanti, mi ha intimato di riprendere “whatever the fuck you have put in the mail box” e di sparire immediatamente. Non era il caso di mettersi a “ragionare” con il tipo in questione. Ho ripreso il bicchiere accartocciato e me ne sono andato sotto il diluvio.

Viste queste premesse (in aggiunta alle migliaia di assassinii virtuali che lo statunitense medio si cucca durante le sue “normali” quattro ore di relax quotidiano di fronte alla tv) il passo per arrivare alle stragi dei “campus” o a qualunque altra strage, è molto breve. A questo punto non ci vuole molto a capire che l’intero circo mediatico di trasmissioni televisive, psicologi, opinionisti, quando accade qualche “fattaccio” del genere, serve unicamente ad instillare, goccia a goccia, paura nella società, per condurla ad essere sempre più malata; una malattia che inevitabilmente può sfociare solo nella morte.
L’intero baraccone mediatico che salta fuori ogni qualvolta c’è una strage, intervallato qua e là dall’intrattenimento più becero cui la gente si sottopone senza batter ciglio (centro commerciale, social network, sport, infinito altro ancora), non è altro che una mega operazione di condizionamento mentale volta ad introdurre una cultura della morte e di conseguenza ad allontanarci dalla Vita. Quella Vita vera che è (dovrebbe essere) pura gioia di vivere.
Tutto quanto sopra non rappresenta però che dei sintomi di una società profondamente malata fin nelle sue viscere, e per ragioni che vanno ben al di là della facilità con cui si possono acquistare armi e alla tanta violenza propagandata dai media.
Sono convinto che alla base di tutto ci sia quel mondo tecno-artificiale che abitiamo (siamo costretti ad abitare) e che ha creato tutt’attorno a noi le barriere insormontabili di una landa morta. Bisogna capire senza troppi “se” e troppi “ma” che quando ci si relaziona (in qualunque attività siamo impegnati e continuamente) con degli oggetti, che per propria natura sono morti, e si vive (si fa per dire) attraverso i social network, si vive in un mondo morto, che di conseguenza crea una società morta che sempre di conseguenza non può amare la Vita.
Bisogna capire senza “se” e senza “ma” che la Natura è viva e se ci relazioniamo con essa siamo vivi anche noi, mentre il mondo che abitiamo è artificiale e morto (e relazionandoci con esso poco alla volta moriamo anche noi). Anche per questo siamo arrivati alle stragi nei campus e a tutte le altre stragi che costellano le nostre esistenze. Ci paiono quasi normali. Ma del resto, costretti a vivere in un mondo morto, siamo arrivati (o stiamo arrivando) ad “amare” più la morte della Vita. Per capirlo sarebbe sufficiente comprendere, come ebbe a scrivere Sepulvéda, che la Vita invece , quella vera, “è e sarà sempre il più bello dei regali”. Si chiamava joie de vivre. Altroché morte e stragi.
CERCA I MIEI LIBRI SU:
www.andreabizzocchi.it
www.macrolibrarsi.it
Articolo riproducibile citando la fonte con link al testo originale pubblicato su Italia che Cambia



